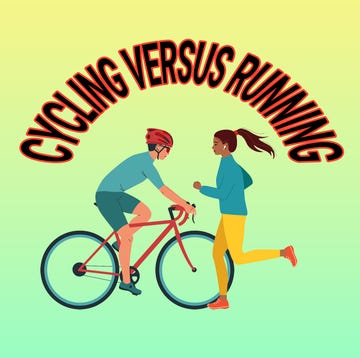Nell’era della performance siamo costantemente esposti a video e articoli motivazionali che esaltano il focus, la disciplina e la preparazione minuziosa per raggiungere un obiettivo, che sia sportivo, professionale o personale.
È innegabile che il raggiungimento di un traguardo richieda impegno, il talento da solo non basta (e forse nemmeno esiste davvero), bisogna allenarsi, studiare, impegnarsi. Tuttavia, portare questo messaggio all’estremo può rivelarsi controproducente.
Ogni passione, se spinta all’eccesso, rischia di trasformarsi in ossessione. E se è vero che l’ossessione può anche portare a risultati straordinari, spesso lo fa a scapito di altri aspetti importanti della vita. Sempre più persone riconoscono oggi il valore della flessibilità, sia nel lavoro che nell’approccio mentale. Niente fraintendimenti, l’impegno è fondamentale, lo ripetiamo, ma è altrettanto importante ritagliarsi momenti di pausa, concedersi delle deviazioni dal percorso, o - per chi non riesce proprio a fermarsi - sperimentare attività alternative che siano comunque utili e soddisfacenti.
Cambiare prospettiva per migliorare
Nel mondo della corsa su strada, chi è ossessionato da cronometro e distanza può trarre beneficio dal provare approcci diversi: allenamenti senza obiettivi di tempo, corse a sensazione, oppure trail running, dove i riferimenti cronometrici passano in secondo piano. Allo stesso modo, il trail runner che rifugge l’asfalto può trovare vantaggio nell’allenarsi in pista o partecipare a una gara su strada, esercizi utili per migliorare atleticamente e sviluppare adattamenti a disagi da riportare poi anche nei momenti di crisi in competizione.
Si tratta in pratica di uscire dalla propria “comfort zone”, osservando così il proprio sport da una prospettiva diversa. Questo non solo aiuta a migliorare la performance, ma anche a riscoprire il piacere dell’attività fisica.
Il pericolo degli esempi sbagliati
Prendere a modello sportivi leggendari può essere motivante, ma spesso porta a cadere nel cosiddetto “bias della sopravvivenza”. Si guarda solo a chi ce l’ha fatta, ignorando la moltitudine che, pur impegnandosi al massimo, non è arrivata al successo, spesso con frustrazione e conseguenze psicologiche.
Kobe Bryant è un esempio classico: la sua mentalità è stata determinante per il suo successo, ma non è detto che lo stesso approccio funzioni per tutti e che chiunque non abbia raggiunto le sue vittorie lo debba imputare solo ad un minor impegno. Meglio allora forse ispirarsi ad atleti che uniscono passione e divertimento. Tadej Pogačar è uno di questi: pedalare per lui sembra un gioco, nonostante l’enorme impegno che il ciclismo richiede.
Guardando il mondo della corsa non si può non pensare a Eliud Kipchoge, simbolo di serenità e determinazione, che ha raggiunto successi incredibili correndo col sorriso. E nel mondo del trail, Kilian Jornet è l’esempio più ovvio: le sue imprese lo connettono in modo profondo con la montagna, dove la fatica diventa un mezzo per vivere un’esperienza appagante e totale, senza essere un sacrificio.
La regola dell’80/20
Qui non si parla della famosa legge di Pareto (usata spesso in economia, sociologia e tanto altro), né della distribuzione dell’intensità negli allenamenti (80% a bassa intensità e 20% ad alta). Una nuova e interessante applicazione dell’80/20 si riferisce al bilanciamento tra concentrazione e distacco: l’80% del tempo dedicato all’allenamento è focalizzato, ma il restante 20% serve per “staccare”, rilassarsi, svagarsi.
Questo principio si può applicare anche alla nutrizione e al riposo, dove un eccesso di controllo porta facilmente al burnout o a uno stress che annulla i benefici dell’impegno.
Flessibilità concreta: fartlek, colline e pista
Quali sono quindi le scelte pratiche per migliorare la propria flessibilità nella corsa? Il runner ossessionato dai ritmi al chilometro può ad esempio sperimentare il fartlek, le corse su terreni collinari o sui sentieri, dove il tempo diventa relativo. All'esatto opposto il trail runner invece può trarre beneficio da allenamenti in pianura o da ripetute su pista, strutturando il lavoro per una crescita fisica e allenando anche la mente a gestire contesti meno familiari.
Liberarsi dall’orologio
L’orologio GPS è un compagno inseparabile per molti corridori, utile per monitorare tempi e distanze ed evitare il sovrallenamento. Ma può diventare anche una gabbia mentale. Molti raccontano di personali battuti proprio nelle rare occasioni in cui si è dimenticato l’orologio a casa. Difficile farne a meno del tutto, certo, ma imparare a correre ascoltando le proprie sensazioni può rivelarsi liberatorio.
Il trail runner spesso è già abituato a farlo. Il podista su strada, invece, tende a controllare ossessivamente il ritmo. Allenarsi a sentire il proprio corpo, controllando i dati solo a fine seduta, può diventare un prezioso allenamento mentale. Questo tipo di consapevolezza sarà utile quando in gara condizioni esterne - pioggia, salite, curve - manderanno in crisi i riferimenti abituali.
Adattarsi alle condizioni
Un’ulteriore forma di flessibilità, spesso trascurata ma fondamentale, riguarda la capacità di adattarsi alle condizioni esterne come meteo avverso, orari scomodi o percorsi non ideali. Il corridore rigido tende a rinunciare all’allenamento se non può seguire il piano originale nei minimi dettagli. Chi sviluppa flessibilità, invece, impara a trarre valore anche da situazioni non ottimali.
Un runner abituato alla corsa mattutina su strada, ad esempio, può provare ogni tanto a cambiare orario, o a sfruttare un pomeriggio piovoso per una sessione sul tapis roulant, concentrandosi su tecnica o cadenza. Un trail runner che trova i sentieri impraticabili per fango o neve può decidere di correre su strada o dedicarsi a un allenamento indoor, magari inserendo esercizi di forza o mobilità. Non è "allenamento perso", ma allenamento adattato, e questa capacità di adattamento è ciò che spesso fa la differenza nelle gare, dove niente va mai secondo i piani.